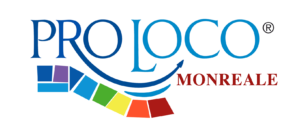L’ARCIVESCOVO TESTA E LA COSTRUZIONE DELLA STRADA-MONUMENTO FRA LA ROCCA E MONREALE
Tutti sanno che Monreale fu fondata nel XII secolo durante la dominazione normanna. In pochi, però, sanno che la cittadina fu rifondata nella seconda metà del XVIII secolo. In quegli anni le sue strade furono ampliate, la scuola riformata, il sistema idrico potenziato. Questa grande opera di urbanizzazione e decoro pubblico trova il suo autore in Francesco Testa, Arcivescovo di Monreale tra il 1754 e il 1773.
Le notizie più precise su Testa ci arrivano dall’abate Secondo Sinesio, che fu suo segretario e dopo la sua morte ne pubblicò la biografia. Recentemente Amelia Crisantino, storica monrealese, ha scavato negli anni dell’arcivescovado di Testa concentrandosi in particolare sugli interventi architettonico-artistici che presero vita durante il suo mandato a Monreale. Tra questi c’è anche la strada che collega Monreale a Palermo.
Lo stradone di Mezzomonreale fu tracciato nel 1583 dal viceré Marcantonio Colonna, che aveva così prolungato l’asse del Cassaro fino al villaggio della Rocca, ai piedi di Monreale, facendone anche la prima strada pubblica alberata. Nel Settecento lo stradone coincide con una delle direttrici di espansione di Palermo, su cui si innesta la strada-monumento realizzata dall’Arcivescovo Testa per collegare Monreale alla capitale.
Sino ad allora, la via di collegamento con Palermo era quella tracciata nel 1575 per volontà dell’Arcivescovo Ludovico I Torres. Questa era stata poi stata riadattata nel 1621 dall’Arcivescovo Venero, che vi aveva posto una lapide: «La strada era prima difficile per gli uomini e per le bestie, impossibile ai carri. Adesso è facile ai carri, è decorata con alberi e vi è stata portata l’acqua da lontano». Ma più di cent’anni dopo la strada era nuovamente malridotta.
Non sappiamo chi ha progettato l’attuale strada-monumento, ma possiamo supporre che sia da ascrivere a due personalità che affiancarono l’Arcivescovo nelle sue iniziative: Ferdinando Lombardo, uno degli ultimi architetti tardobarocchi, oppure il principe Alessandro Vanni, più vicino alla cultura romana e al neoclassicismo, che spesso compare negli atti notarili in sostituzione dell’Arcivescovo.
Il 16 ottobre 1762 viene stipulata l’obbligazione fra i mastri monrealesi Innocenzo e Giuseppe Polizzi e l’Arcivescovo Testa. A partire da questo momento il cantiere prosegue senza interruzioni, le sue fasi sono dettagliatamente documentate negli atti notarili del notaio monrealese Domenico Pensato. Per realizzare la strada fu necessario cominciare facendo saltare le rocce, e ancora nei registri del cantiere risultano le giornate di lavoro, i soldi pagati e la quantità di esplosivo utilizzata.
Dai contratti e dai pagamenti rinvenuti e dalle minuziose relazioni emergono infatti i nomi delle maestranze, i costi, le informazioni tecniche sull’esecuzione dei lavori. I documenti conservano la memoria di un mondo ormai lontano, del quale non comprendiamo le tecniche e qualche volta nemmeno i nomi degli strumenti utilizzati o degli oggetti descritti.
Nella via-monumento le sculture sono affidate a Ignazio Marabitti, l’artista che – a cominciare dalle statue realizzate per la facciata del duomo di Siracusa – per un trentennio mantiene un rapporto privilegiato con Francesco Testa. Partendo dalla Rocca, dirigendosi verso Monreale, la strada si apre con un ingresso sottolineato da due piloni con vasotti che recano iscrizione latina e greca, per rimarcare i meriti degli insegnamenti impartiti nel Seminario di Monreale. I piloni ancora in loco sono di Filippo Pennino, primo allievo di Marabitti e figlio d’arte.
La strada si delinea con due curve a gomito incise nella roccia. All’interno della prima curva è collocata la Fontana del Pescatore, così chiamata per un fanciullo scolpito nell’atto di pescare. Ha vasca circolare, putti ed elementi naturalistici. Nel 1769, ai lati della fontana vengono collocate due grandi edicole marmoree con iscrizioni redatte dal padre scolopio Giuseppe Antonio Guglieri – docente di matematica nel Seminario – che firmano l’opera «affinché del beneficentissimo padre la memoria non sia ai posteri ignota». In origine – e sino al 1938 – le due edicole erano collocate sul bordo interno della strada, quasi degli ingressi nel giardino ideale che ospitava la fontana.
Altri piloni con vasotti di Filippo Pennino segnano il punto in cui la nuova strada interseca la vecchia: un tempo c’erano sedili di pietra ai cui lati s’innalzavano piramidi; in mezzo stavano due iscrizioni che rendevano merito all’Arcivescovo che quella strada aveva realizzato.
L’interno della seconda curva è occupato da un sedile semicircolare, delimitato da pilastri. È quanto resta di un più complesso inserto architettonico, con piramidi e iscrizioni che accompagnavano il viandante: «pensi prima talun, qual via ne prenda, / poiché torcer non suol, presa una volta».
A metà strada nel rettilineo è posto il monumento più scenografico, la Fontana del Drago. Con il suo profilo piramidale riproduce uno schema-tipo già presente nel Seicento palermitano: il drago è metafora delle tenebre destinate ad essere sconfitte, la conchiglia in primo piano – tipica del decorativismo barocco – viene enfatizzata come simbolo di Palermo, fertile “conca d’oro” che accoglie le acque versate dal fiume Oreto. La composizione finale sfrutta il dislivello della montagna, dando l’idea che i fanciulli sfuggano al drago scalando il monte.
Dopo la magnificenza della Fontana del Drago, l’ultima fonte prima del paese ha uno stile più sobrio ed è accompagnata da un’iscrizione che chiude la strada, in ideale continuità con i piloni di Filippo Pennino che ne segnano l’ingresso. Le iscrizioni sono un’ode alla bellezza della capitale, si rivolgono al viandante e quasi lo accompagnano, «perché l’alma Palermo a te più piaccia / né troppo vil ti sia quel che qui miri / quando colà ten vai, non quando torni / tai fonti, e via, o passegger riguarda».
Nel luglio 1767 la strada è compiuta. Si ferma davanti la porta di San Michele e, perché non sfigurasse al confronto, si ristruttura la zona sino alla piazza del Duomo: si ripara quella che era la via di accesso al paese, vengono pitturati i prospetti delle abitazioni e rimesse a nuovo le facciate, le porte e anche gli interni delle dimore.
La strada arredata con fontane e sculture lascia sullo sfondo la sua natura di via di collegamento con la vicina capitale: è ammirata dai contemporanei come un manufatto architettonico e viene così descritta dai viaggiatori che nell’ultimo scorcio del XVIII secolo scoprono la Sicilia.
Il più famoso è Johann Wolfgang Goethe, nell’isola nel 1787, che tace sui mosaici del duomo ma non sulla strada e scrive «oggi siamo saliti a Monreale: magnifica via fatta costruire dall’abate del monastero in tempi di grande abbondanza, larga, di comoda salita, con alberi a destra e a sinistra, ma soprattutto provvista di copiose fontane e getti d’acqua con fregi e ornamenti».
Per approfondire l’argomento:
Amelia Crisantino, Magnificenza e decoro: L’arcivescovo di Monreale Francesco Testa, l’architettura e le arti (1754-1773), Studi e ricerche – Mediterranea. Ricerche storiche, 2012